Cultura & Spettacolo
Pausa di Riflessione – I nostri peccati e la nostra autoassoluzione

Due domeniche fa mio figlio ha “fatto” la sua prima Comunione e, in quell’occasione, sono riaffiorate alla mia memoria alcune scene della mia prima Comunione.
A dire il vero, quello che ricordo di allora è ben poco, ho solo delle immagini sbiadite davanti agli occhi, oltretutto falsate nella loro essenza dal fatto che molto probabilmente esse sono il frutto di sensazioni e di impressioni derivanti non dal ricordo diretto, ma da quello che ho ricavato dalla visione di quelle poche foto in mio possesso. Foto tra l’altro neanche molto nitide, a causa dell’azione del tempo e della non professionalità dell’operatore, allora non supplita, come accade oggi, dalla tecnologia, che consente a chiunque di ottenere delle immagini di buona qualità ed in quantità inutilmente elevata. Chissà, infatti, quante di esse resteranno ai nostri figli, e se regaleranno loro quelle stesse sensazioni che proviamo noi quando prendiamo tra le mani, quelle vecchie foto, staccandole da qualche album con le pagine che si mantengono insieme a stento, grazie a sapienti restauri casalinghi, fatti dai nostri nonni e dai nostri genitori, o trovandole sparse a mucchietti nei cassetti.
Quei cassetti che quando li apriamo ci restituiscono l’odore che ci riporta, se non al periodo in cui sono state scattate le foto, a epoche quando tutto sapeva di buono. Quelle foto nelle quali ci immergiamo, cercando di cogliere lo stato d’animo delle persone raffigurate in esse, che potevano avere nel momento in cui venivano immortalate nello scatto. E’ come se i soggetti parlassero di loro delle loro aspirazioni, delle loro preoccupazioni o delle loro gioie. E se eravamo noi al centro dell’obbiettivo, tentiamo di indagare per scoprire quale fosse il nostro stato d’animo, nella speranza che si sia cristallizzato nella fotografia, venendo in soccorso alla evanescenza della nostra memoria.
La difficoltà di reperire nei miei ricordi immagini più chiare della mia prima Comunione dipende anche dal fatto che a quell’epoca avevo solo sette anni. Erano i primi anni sessanta, ed allora il sacramento della prima Comunione veniva somministrato a quella età che coincideva con il periodo in cui si frequentava la seconda o la terza elementare, cioè qualche anno prima rispetto ad oggi, e quasi sempre era associata alla Cresima. L’aver fatto slittare l’età per ricevere questo sacramento ritengo sia stata una buona idea, perché questi pochi anni in più consentono al ragazzo di acquisire una maggiore coscienza, tanto da garantire una sua partecipazione attiva, evitando che egli si accosti a questo sacramento, senza consapevolezza, come purtroppo avviene con il Battesimo.
 Ma, è sul sacramento della confessione che si è soffermata la mia attenzione. Prendendo in considerazione il fatto di voler “fare” anch’io, dopo tanti anni, la Comunione, ho provato a riassumere nelle mente i peccati che avrei dovuto dire al prete. Si trattava di fare una loro ricognizione, ma per fare ciò era necessario essere in grado di saper stabilire cosa fosse un peccato grave da confessare e cosa non lo fosse. Ho capito subito che non si trattava di un’operazione semplicissima. Il motivo di questa difficoltà era dovuto al fatto che se avessi dovuto fare riferimento a quelli che vengono ritenuti peccati “mortali”, ormai codificati, come rubare o uccidere, cioè quelli la cui gravità non può essere messa in dubbio da nessuna religione, non avrei avuto nessuna incertezza ad individuarli. D’altronde, per fortuna, questi peccati non sono molto diffusi. Sono altri i peccati, anch’essi “mortali”, ad essere molto diffusi e che noi tentiamo di eludere o più semplicemente non riconosciamo o non percepiamo come tali, finendo per declassarli a peccati veniali, di poco conto, che non recano danni a nessuno e che pertanto non richiedono una confessione.
Ma, è sul sacramento della confessione che si è soffermata la mia attenzione. Prendendo in considerazione il fatto di voler “fare” anch’io, dopo tanti anni, la Comunione, ho provato a riassumere nelle mente i peccati che avrei dovuto dire al prete. Si trattava di fare una loro ricognizione, ma per fare ciò era necessario essere in grado di saper stabilire cosa fosse un peccato grave da confessare e cosa non lo fosse. Ho capito subito che non si trattava di un’operazione semplicissima. Il motivo di questa difficoltà era dovuto al fatto che se avessi dovuto fare riferimento a quelli che vengono ritenuti peccati “mortali”, ormai codificati, come rubare o uccidere, cioè quelli la cui gravità non può essere messa in dubbio da nessuna religione, non avrei avuto nessuna incertezza ad individuarli. D’altronde, per fortuna, questi peccati non sono molto diffusi. Sono altri i peccati, anch’essi “mortali”, ad essere molto diffusi e che noi tentiamo di eludere o più semplicemente non riconosciamo o non percepiamo come tali, finendo per declassarli a peccati veniali, di poco conto, che non recano danni a nessuno e che pertanto non richiedono una confessione.
A dire il vero quella che si sta estinguendo è la coscienza del peccato in generale. Così c’è il rischio, da una parte, che la mancanza della percezione della gravità di certe nostre azioni o omissioni e l’assenza di consapevolezza delle loro conseguenze ci possa portare ad autoassolverci, e, dall’altra, quello che perdendo la coscienza di alcuni peccati e non ritenendoli tali si possa arrivare alla dissoluzione del confine tra il bene ed il male.
Affinché ciò non avvenga è necessario tener presente, innanzitutto, che il peccato non può essere considerato un fatto che interessa solo la sfera personale (un fatto da risolvere tra noi e Dio), quindi una questione individuale, ma va considerato nella sua dimensione sociale. Evadere le tasse e non rispettare la natura, ad esempio, sono azioni che coinvolgono altre persone e pregiudicano anche il loro benessere e quello delle future generazioni, e sono dovute al nostro egoismo. Dal lato opposto, c’è la mancanza di amore verso se stessi, che può condurre all’annientamento della persona, attraverso la scelta di strade tortuose come quelle della droga. Poi vi sono altri peccati, altrettanto gravi, come il consumismo sfrenato, la ludopatia, la corruzione, ed infine i peccati informatici, come la diffamazione tramite i social, il cyberstalking, la creazione di falsi account per effettuare truffe di vario genere, la pirateria informatica e l’ hackeraggio.
Essendo così numerosi ed alcuni non avvertiti come tali, non si può escludere che possiamo dimenticarne qualcuno durante la confessione. Ma, questo non sarebbe grave. Sarebbe grave volerli spiegare, per giustificarli, per ridurli a banali peccati “veniali”. Certi peccati andrebbero, anzi, stigmatizzati, dai ministri di ogni culto e di ogni religione, per evitare che i fedeli si possano assuefare ad essi, per poi passare all’autoassoluzione. Ma, al di là dei precetti religiosi, per non commettere peccati gravi basterebbe far propria una frase di una canzone di Gino Paoli che dice: “…anche se non credo in Dio non mi comporto male”.






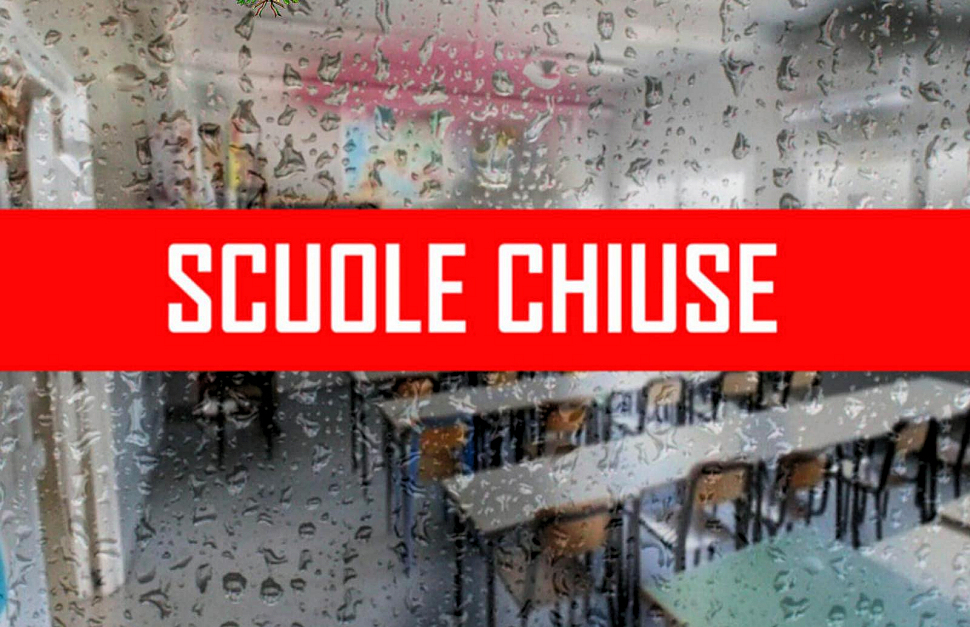






Social