Cultura & Spettacolo
Pausa di Riflessione – Il ronzio di un moscone ed il frinire delle cicale

Da una recente ricerca californiana sembrerebbe che mediamente circa 100.000 parole raggiungono quotidianamente la nostra corteccia cerebrale.
Al di là della loro qualità, è indubbio che, già solo per la loro elevata mole, esse rappresentino una notevole fonte di inquinamento acustico, che si ripercuote negativamente sulla nostra psiche. Questo rumore esterno va a sommarsi a quello che è già presente dentro di noi e che è il prodotto delle opinioni altrui sui nostri comportamenti, delle aspettative dei nostri amici su di noi, o delle paure per la sicurezza dei nostri figli, che ci attanagliano e ci angustiano. Se poi consideriamo la qualità di tali informazioni, ci accorgiamo che alcune di esse possono sortire su di noi un effetto devastante, capace di determinare uno scompenso vero e proprio, anche in una mente “normale”, che potrebbe avere già serie difficoltà a mantenere un suo “equilibrio”.
Del resto, come potrebbero non causare ciò, notizie come quelle di bambini che muoiono dopo atroci sofferenze provocate dal gas nervino, o che durante un viaggio che dovrebbe salvarli dalla guerra, dalla quale fuggono, trovano in un barcone o nelle gelide acque del mare la fine della loro misera esistenza, o episodi come quello del padre che uccide i propri figli e si toglie la vita perché pensa di non poter garantire loro un futuro?
Questi fatti suscitano in noi un senso di impotenza, risvegliano le nostre paure e ci richiamano al nostro senso di responsabilità. Una delle paure che emerge con più forza è quella della malvagità umana, che nasce già con il sospetto sulle intenzioni malvagie di chi ci sta intorno, e con le minacce, vere o presunte che a noi sembra di cogliere costantemente. Sebbene questo genere di paura sia stato sempre presente, oggi esso acquista maggiore rilevanza, perché si è perso il senso della comunità, che in qualche modo offriva protezione ai singoli componenti e dava loro maggiore coraggio. Al suo posto è subentrata una forma di individualismo, che costringe ognuno a provvedere da solo alla propria salvaguardia, senza poter fare affidamento sugli altri membri della stessa comunità. Nascono così i nostri tremori esistenziali. Tra questi c’è quello dovuto alla paura per la sicurezza e per l’incolumità dei nostri figli, che ci fa avvertire il dovere di salvaguardarli e di proteggerli, lungo i tre fronti dove essi risultano più esposti: quello delle forze della natura, della debolezza del corpo e soprattutto dell’ostilità altrui.
In alcuni casi, possono venire a galla anche i sensi di colpa, quando, ad esempio, sono coinvolti nelle vicende bambini come i nostri, figli di gente per noi senza volto, ma che di certo ha il nostro identico sentire di fronte a loro, l’identico dovere e l’identico diritto di assolvere quel ruolo che noi abbiamo nei confronti dei nostri: quello di proteggerli. Allora capiamo che garantire loro questa possibilità non solo è un fatto di giustizia, ma è anche un modo per farci stare bene con la nostra coscienza. Infatti, come possiamo chiudere la nostra porta sapendo, come dice un noto cantautore, che dietro un’altra porta, magari quella accanto, “c’è un altro bimbo uguale al nostro che ha bisogno di sognare…”?
Tormentata da queste paure e sotto il peso del senso di responsabilità, che sappiamo di dovere mettere in campo, non potendo oggi delegare nessuno, in questo compito, a differenza di quando eravamo bambini, quando erano i nostri genitori a provvedervi, la nostra mente va alla ricerca di una tregua. Per evadere da questa cappa opprimente potrebbe bastare, in un giorno di inizio estate, quando fa molto caldo, cercare rifugio in campagna. Qui il semplice ronzare di un moscone potrebbe riportarci alla memoria quelle giornate di piena estate, al mare o in campagna, durante l’infanzia o la preadolescenza, in quei pomeriggi assolati, quando venivamo costretti dai nostri genitori a restare in casa di malavoglia, distesi sul letto o nel giardino su un a sdraio, ad aspettare che passassero quelle ore particolarmente calde, ritenute da loro, per noi, pericolose. Ci accompagnava, molto spesso, in quella sosta forzata, il ronzio tenace di un moscone, sul sottofondo del frinire incessante delle cicale, mentre eravamo immersi in una calura che rendeva insopportabile, per noi ragazzi, quella situazione di immobilità. I nostri genitori sembravano invece godere di quelle ore, di quei momenti, in una sorta di rapimento estatico.
A distanza di tanti anni capisco, chiudendo gli occhi disteso su un’amaca, all’ombra, nel giardino, lasciandomi cullare da quei suoni ipnotizzanti, quanto possano risultare benefici, momenti come questi, perché ci riportano attraverso un seducente dormiveglia, a quell’epoca in cui eravamo noi ragazzini, quando i pensieri non si affollavano nella mente e non andavano a turbare la nostra serenità; non potevano farlo, per un motivo molto semplice: perché alla sua salvaguardia erano preposti loro, i nostri genitori.






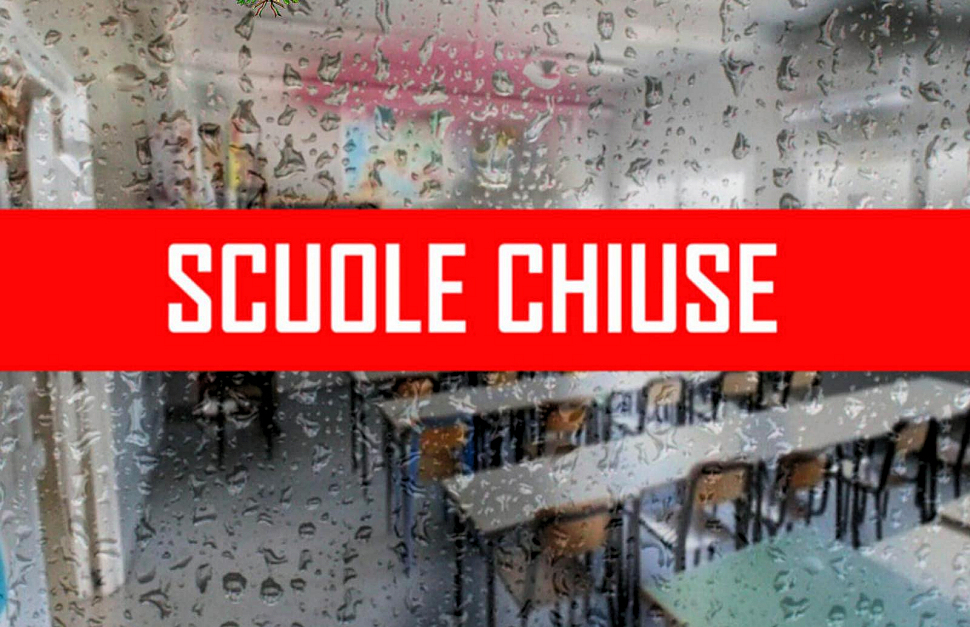






Social