Cultura & Spettacolo
“Cibiamoci di tradizioni”: a Palazzo Arnone storie ed emozioni del Natale in Calabria

L’iniziativa è stata promossa dal tour operator “Le Vie della Perla – Viaggiare in Calabria” e patrocinato dal Comune di Cosenza.
COSENZA – “Cibo e tradizioni in Calabria” è stato il tema del convegno svoltosi venerdì, nella Sala conferenze di Palazzo Arnone, con al centro il cibo visto come elemento di relazione e interazione e come rimando alle tradizioni culturali e popolari della nostra regione.
Un tema, come si legge nella presentazione a cura del Comune, che “dimostra, una volta di più, che la Calabria, e Cosenza in particolare, sono ricche di quei sapori che sono anche dei saperi. La promozione turistico-culturale non può non passare attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni e del gusto come elemento che connota la nostra identità”.
L’iniziativa, ideata dalla dottoressa Paola Bisciglia, psicologa e psicoterapeuta, ha inteso soprattutto focalizzare l’attenzione sulle storie e le emozioni del Natale in Calabria.
La serata strutturata come un vero e proprio pranzo con le sue portate, ha visto un primo intervento (antipasto) della stessa dottoressa Bisciglia sul tema “Tutti a Tavola! Tra profumi e sapori la famiglia si racconta”
La dottoressa Bisceglia, partendo la concetto di famiglia intesa come sistema che interagisce e influenza reciprocamente i propri membri, ha sottolineato l’importanza che riveste la tavola soprattutto nel periodo natalizio. La tavola che costituisce il centro dell’azione della famiglia, dove avviene la comunicazione e dove il cibo serve a creare i legami più profondi e dove si impara a osservare regole comuni e condivise.
È seguito l’intervento (primo piatto) del prof. Fulvio Librandi, docente di Antropologia culturale dell’Università della Calabria, con un intervento sul tema “Alla stessa mensa. La tradizione del tempo che viene”. Il professore Librandi ha descritto la nascita del mito e della figura di Babbo Natale, visto come una figura tradizionale che pur mutando nel tempo e nei luoghi ha rappresentato una mediazione tra culture diverse.
Si è partiti da san Nicola, greco del IV secolo d.C. vescovo di Mira in Asia Minore, l’attuale Turchia. Nicola si guadagnò la reputazione di fiero difensore della fede cristiana in anni di persecuzioni e dopo la sua morte (avvenuta il 6 di dicembre di un anno imprecisato alla metà del IV secolo), la sua figura del santo divenne popolarissima in tutta la cristianità, grazie anche ai tanti miracoli che gli furono attribuiti e che interessarono bambini e adolescenti.
Per molti secoli il culto di san Nicola fu legato alla tradizione di fare regali ai bambini il 6 dicembre, come avviene tuttora in diverse zone del Nord Europa.
Col tempo venne attribuito al santo anche il ruolo di sorvegliare i bambini perché facessero i buoni e dicessero le preghiere.
Molti secoli dopo gli immigrati nordeuropei portarono con loro, anche se il Natale era molto diverso da come lo consideriamo oggi: una specie di festa pagana dedicata soprattutto al massiccio consumo di alcol.
La figura del santo cambia ancora nei primi decenni dell’Ottocento, quando si comincia a guardare al Natale come a una festa di famiglia e diviene Santa Claus che porta doni ma impone anche punizioni ai bambini cattivi. Agli inizi del ‘900, grazie anche a una mirata operazione di marketing, la Coca-Cola, per aggirare il divieto di utilizzare bambini nella pubblicità, scelse come testimonial proprio la figura di Babbo Natale, vestito di rosso (colore del marchio della bevanda) con i bordi di pelliccia bianca.
Dopo la figura di Babbo Natale/San Nicola, il professore Librandi è passato a esaminare l’origine della data del 25 dicembre, scelta per festeggiare il giorno di Natale.
Si tratta di un giorno di festa che presenta una grande quantità di commistioni culturali e religiose della storia umana, che spaziano dalla Siria, all’Egitto, alla Mesopotamia, alla Persia, all’Arabia e alla stessa antica Roma.
E proprio a Roma il 25 dicembre comparve per la prima volta nel 274 D.C. per ordine dell’Imperatore Aureliano che fece diventare Festa Ufficiale il Natale del Sole e la volle celebrata in tutto l’Impero Romano.
Il 25 dicembre, il quarto giorno dopo il Solstizio, rappresentava infatti il Sol Invictus, mentre dopo 12 giorni da questa ricorrenza si festeggiava la morte e la rinascita della natura rappresentata della figura pagana di Madre Natura.
Un’altra leggenda, infine, collega la tradizione dei regali del 6 gennaio alla festa romana che si svolgeva all’inizio dell’anno in onore del dio Giano e alla dea sabina Strenia (simbolo del nuovo anno, di prosperità e buona fortuna) e durante la quale si scambiavano i regali. Da qui il nome l’origine alla parola italiana “strenna” (declinata nei vari dialetti) che ha assunto il significato di regalo natalizio.

A seguire un’ampia e articolata relazione (secondo piatto) su “I romanzi e le tradizioni calabresi all’estero”, tenuta dalla professoressa Margherita Ganeri, docente di Letteratura italiana contemporanea e di Cultura e Letteratura italo-americana all’Università della Calabria.
La professoressa Ganeri ha sottolineato il fatto che mentre nella letteratura italiana non esistono tracce evidenti delle tradizioni alimentari natalizie, molto invece si è stato scritto dagli autori e soprattutto dalle autrici italoamericani.
La Ganeri è partita delle ondate migratorie originate dall’Italia, a partire dalla cosiddetta «grande migrazione» di fine Ottocento, descrivendo gli atteggiamenti degli immigrati protagonisti di una progressiva integrazione nella nuova società che li ha accolti.
Si parte da una prima generazione di immigranti i quali, agli atteggiamenti di diffidenza e di rifiuto da parte della popolazione americana, contrappongono il mantenimento quasi ossessivo delle proprie tradizioni soprattutto gastronomiche. La seconda generazione (figli), invece, si trova a rifiutare gran parte delle abitudini culturali d’origine perché è già assimilata alla tradizione americana o vuole esserlo fortemente.
La terza generazione (nipoti) ribalta gli atteggiamenti dei genitori recuperando con entusiasmo le tradizioni perduta di nonni o bisnonni. Essi scelgono recuperare soprattutto le tradizioni culinarie dei paesi di origine, assumendo il cibo come un importantissimo elemento della propria socializzazione.
A questo proposito, sottolinea la professoressa, molti sono gli esempi di autrici italoamericane che raccontano il loro rapporto con il cibo in modo interessante.
Esse lo fanno, in parte per ricostruire la storia della propria identità, attraverso la storia delle migrazioni passate e delle tradizioni gastronomiche del paese di origine, ma soprattutto per affermare il proprio ruolo in una società assolutamente maschilista come quella italoamericana.
Il finale comico satirico (dolce), infine, è stato affidato al noto umorista cosentino Nunzio Scalercio che ha piacevolmente intrattenuto i presenti sul tema “In turdillo veritas”.






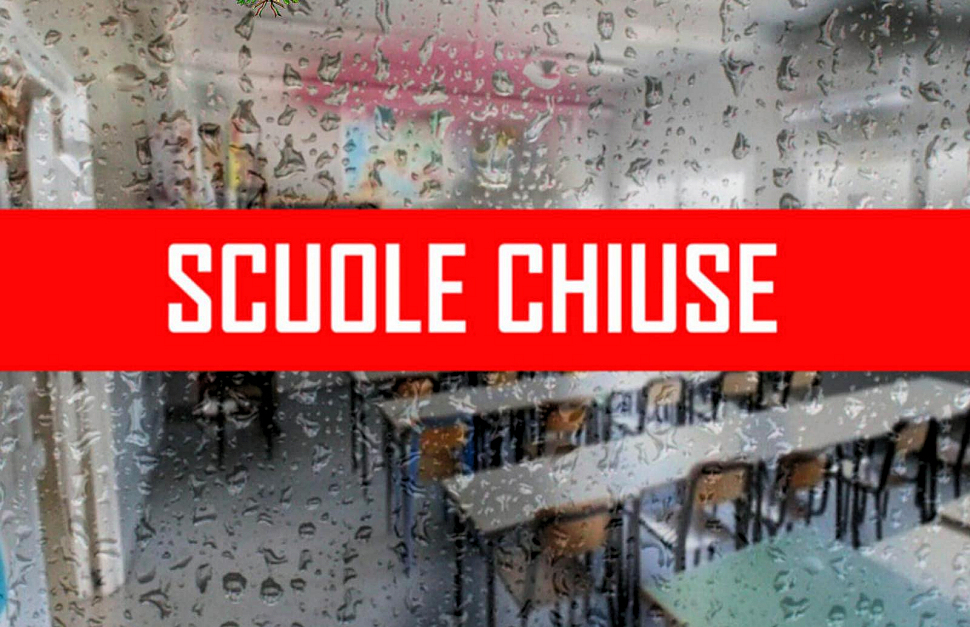







Social