Archivio Storico News
Viene a trovarmi Simone Signoret
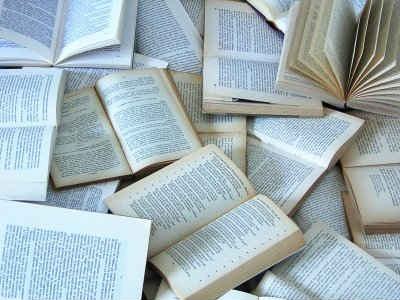
Nonostante una censura ottusa e crudele, gli autori iraniani hanno prodotto film acclamati in tutto il mondo. Parte da qui la storia di Bijan Zarmandili, Viene a trovarmi Simone Signoret.
Quanto dovremmo essere grati al cinema iraniano, non fosse altro perché ha sempre tenuto lo sguardo aperto su una società che nella percezione occidentale viene facilmente assimilata a despoti barbuti, mullah gesticolanti e donne in chador. I registi iraniani ci hanno sempre dato immagini diverse: dalle parabole filosofiche di Abbas Kiarostami sull’amore e la morte ai panorami sociali di Jafar Panahi, che raccontavano l’impotenza – soprattutto delle donne, in famiglia, o alla biglietteria di una stazione di autobus dove senza l’approvazione del marito non possono comprare un biglietto – ma anche la sfrontatezza delle ragazze davanti a uno stadio dove è loro proibito entrare. E poi i più giovani che come Ashghar Farhadi hanno portato sullo schermo il sentimento della vita delle nuove generazioni che abitano le città, guardano a occidente, studiano e telefonano con gli smart phones, cercando su internet un mondo più vasto di quello previsto dai guardiani della morale islamica.«È un miracolo» dice l’autore «che nonostante la rivoluzione, nonostante otto anni di guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein, e nonostante la repressione sia nata un’arte cinematografica che ha conquistato il mondo». L’autore non è lui stesso uomo di cinema, come si potrebbe pensare leggendo il romanzo. La sua strada è stata quella del giornalismo e della letteratura. Ma è figlio d’arte, il padre dirigeva il più grande cinema di Teheran, il Metropole, e da ragazzo passava i pomeriggi nelle loges riservate ai vip a vedere i film che il padre, negli anni Cinquanta e Sessanta, importava dall’Italia soprattutto, oppure dalla Francia, ed erano quelli che gli piacevano di più: i noir con Jean Gabin nelle brume bretoni o una protagonista bionda «con la sigaretta all’angolo della bocca e l’aria di chi se ne infischia di tutto e di tutti», come Simone Signoret. Il cinema, allora, era in Iran una grande passione. L’industria cinematografica iraniana era la seconda in Asia dopo quella indiana. I film iraniani mandavano in visibilio il popolo, sembra che nelle città dove c’era un cinematografo, ed erano molte, fino all’ultimo degli abitanti nessuno si perdesse mai un film. Le trame erano semplici: due protagonisti, lui un bullo di uno dei quartieri più malfamati della città che passava le giornate a giocare a carte e bere grappa con gli amici, lei una ballerina da bar che s’innamorava di lui e cercava di strapparlo alla famiglia. Ma il bullo era comunque uomo di tradizioni, che naturalmente avevano le loro radici nella religione, e così un momento prima di perdersi ritrovava le radici, si pentiva dei suoi peccati e piantava la ballerina. L’ultima scena era sempre in un santuario dove l’uomo pentito accendeva una candela e si affidava all’infinita misericordia di Dio. Se la borghesia avesse visto questi film forse avrebbe potuto prevedere il travolgente successo dell’ayatollah Khomeini pochi anni dopo. Ma la borghesia preferiva, come l’autore del romanzo, vedere i film d’importazione europea. Bijan Zarmandili ha deciso di scrivere questo libro quando, nel 2010, arrivò la notizia che Jafar Panahi era stato condannato a sei anni di reclusione e al divieto di dirigere, scrivere e produrre film per vent’anni. «Avrei potuto capire che lo condannassero alla prigione come dissidente, i regimi autoritari hanno sempre agito così» dice Zarmandili «ma il divieto di lavorare per vent’anni fu uno shok. Era, quella del regime, una reazione infantile, quella di un bambino capriccioso che risponde senza capire quello che fa». Così è nato il romanzo. È la storia di un regista, ormai anziano e sostanzialmente fallito perché i suoi film non sono mai piaciuti al pubblico, che ha conservato il sogno di fare un noir alla francese. Ciangiz, così si chiama il regista, finisce in carcere perché accusato di «ammiccamenti al sionismo» dopo aver chiesto il permesso per girare un film il cui protagonista è ebreo. La storia si svolge negli anni 70, poco prima che lo scià lasciasse l’Iran e Teheran si preparasse all’accoglienza trionfale di Khomeini. Due ragazzi, lui ebreo lei musulmana, abitano nello stesso quartiere e tra una manifestazione contro lo scià e una lettura di poeti dissidenti scoprono di essere innamorati. Una storia d’amore, di morte e di rivoluzione che Ciangiz non rinuncia dalla sua cella a girare, immaginando ogni dettaglio come se lo guardasse alla moviola. Finché la moglie Ozra, che lo aspetta fuori dal carcere, diventa per lui Simone Signoret. Il libro è un omaggio alla meraviglia del cinema e alla fervida immaginazione degli iraniani.

















Social